
VINCENZI PRESIDENTE DI TURNO EUWMA
.png) Si tiene, lunedì 23 Ottobre 2023 in sede ANBI a Roma, l’annuale Assemblea EUWMA (European Union of Water Management Associations), cui aderiscono le organizzazioni pubbliche, locali e regionali di gestione dell’acqua di 10 Stati, membri dell’Unione Europea: Belgio, Italia, Ungheria, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Romania e Paesi Bassi.
Si tiene, lunedì 23 Ottobre 2023 in sede ANBI a Roma, l’annuale Assemblea EUWMA (European Union of Water Management Associations), cui aderiscono le organizzazioni pubbliche, locali e regionali di gestione dell’acqua di 10 Stati, membri dell’Unione Europea: Belgio, Italia, Ungheria, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Romania e Paesi Bassi.
Nell’occasione, il Presidente ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue), Francesco Vincenzi, assume la Presidenza di turno europea. I lavori dell’Assemblea EUWMA proseguono nella mattinata di martedi’ 24 Ottobre con la visita alla sede dell’impianto irriguo del Consorzio di bonifica Litorale Nord, a Maccarese (viale Monti dell’Ara) per poi trasferirsi nella sede di ANBI Lazio a Fiumicino (via delle Idrovore, 304) per i saluti finali.
L’EUROPA PUBBLICA LA PRIMA MAPPA DEL RISCHIO ALLUVIONI
VINCENZI: “DATI E CONOSCENZA DEI TERRITORI SONO FONDAMENTALI PER MITIGARE LE CONSEGUENZE DELLA CRISI CLIMATICA”
NEL LAZIO NUOVA SENSORISTICA MONITORERA’ IL LAGO DI ALBANO
Sono oltre quattordicimila le zone dell’Unione Europea a significativo rischio di alluvioni; tali fenomeni sono le catastrofi naturali più comuni e le loro conseguenze sono devastanti non solo per le vite umane, ma anche per la biodiversità e per le gravi perdite economiche, che comportano.
“Secondo uno studio del mondo assicurativo, i costi per danni da cambiamenti climatici sono cresciuti, in 10 anni, del 5,7% a livello internazionale, ma del 46% in Italia” ha precisato Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI.
Nei prossimi decenni si assisterà probabilmente ad un aumento del rischio di alluvioni in Europa, con le conseguenze, che ne derivano ed è questo uno dei temi, che sarà affrontato dall’annuale Assemblea EUWMA (European Union of Water Management Associations), in calendario a Roma, lunedì 23 Ottobre p.v..
"I costi umani ed economici delle recenti alluvioni in Slovenia e in Grecia sono stati devastanti - ha dichiarato Virginijus Sinkevi?ius, Commissario Europeo Ambiente, Oceani e Pesca - Tali fenomeni meteorologici estremi sono purtroppo sempre più frequenti nell'UE e nel mondo, per cui dobbiamo prepararci meglio e adeguarci. Per attenuare efficacemente i rischi climatici che ci troviamo ad affrontare, abbiamo bisogno di informazioni affidabili.”
.jpg) Per questo, la Commissione Europea ha pubblicato on-line un nuovo strumento che. per la prima volta, fornisce una mappa unica delle zone a rischio significativo di alluvione ed un portale di accesso a tutte le informazioni correlate, fornendo ai decisori una visione d’insieme. I dati sono forniti dagli Stati membri e comprendono le valutazioni preliminari del pericolo di alluvioni, le mappe ed i piani di gestione del rischio.
Per questo, la Commissione Europea ha pubblicato on-line un nuovo strumento che. per la prima volta, fornisce una mappa unica delle zone a rischio significativo di alluvione ed un portale di accesso a tutte le informazioni correlate, fornendo ai decisori una visione d’insieme. I dati sono forniti dagli Stati membri e comprendono le valutazioni preliminari del pericolo di alluvioni, le mappe ed i piani di gestione del rischio.
“La disponibilità di dati è la condizione preliminare ad ogni politica di adattamento alla crisi climatica – ha evidenziato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI e prossimo Presidente di turno di EUWMA – Per questo, nei Consorzi di bonifica è in atto una forte accelerazione tecnologica, che non è sostitutiva, ma integrativa dell’esperienza umana, maturata sui territori. Da qui – ha concluso Vincenzi - le partnerships con primari gruppi industriali, ma anche con le Autorità di bacino distrettuale come nel caso del lago di Albano, dove sarà installata una rete sensoristica per monitorare le condizioni del bacino laziale, da tempo in crisi idrica.”
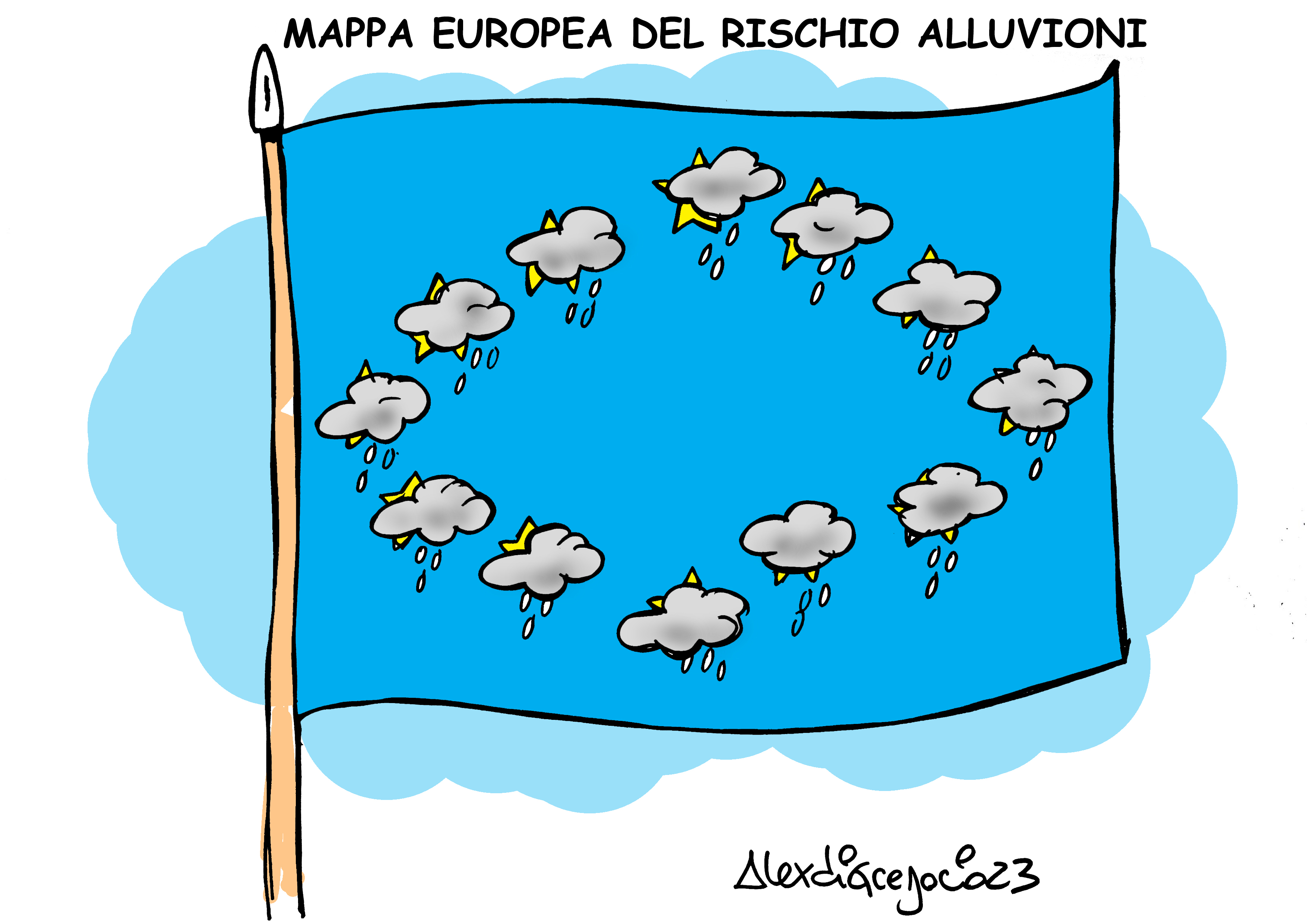
ANCHE AL NORD TERRITORI A RISCHIO DESERTIFICAZIONE LOCALIZZATA PRIMO ALLARME SICCITA’ ARRIVA DI NUOVO DAL CUNEESE
All’inizio dell’autunno torna lo spettro della siccità sulla provincia di Cuneo, dove già nei mesi scorsi erano comparse anche le autobotti per l’uso idrico potabile; ciò conferma la tendenza a casi di desertificazione localizzata anche nel Nord Italia e già fotografati dai satelliti. A lanciare l’allarme è l’Associazione Consorzi Irrigui Risorgive Mellea Centallese, che segnala la persistente carenza idrica, che investe l’asta del torrente Grana-Mellea a causa dell’andamento climatico.
 “È quanto mai urgente – ha affermato il Presidente dell’ente, Adriano Paoletti - prevenire le criticità per salvare il cibo prodotto in un vasto comprensorio del Cuneese, che rischia di trasformarsi da pianura irrigua, fertile e produttiva in una landa arida. Per questo occorre programmare ora le iniziative di contrasto all’emergenza, studiandone le modalità operative con le Pubbliche Amministrazioni e puntando sull’inizio anticipato dell’irrigazione a Marzo così da procedere alle semine primaverili.”
“È quanto mai urgente – ha affermato il Presidente dell’ente, Adriano Paoletti - prevenire le criticità per salvare il cibo prodotto in un vasto comprensorio del Cuneese, che rischia di trasformarsi da pianura irrigua, fertile e produttiva in una landa arida. Per questo occorre programmare ora le iniziative di contrasto all’emergenza, studiandone le modalità operative con le Pubbliche Amministrazioni e puntando sull’inizio anticipato dell’irrigazione a Marzo così da procedere alle semine primaverili.”
Oltre a ciò, da tempo a Provincia di Cuneo e Regione Piemonte sono state proposte soluzioni divenute ormai indifferibili: avviare al più presto le operazioni annuali di preparazione delle dighe mobili sui corsi d’acqua; studiare ulteriori deroghe al Deflusso Ecologico in ottemperanza alla riconosciuta priorità della produzione alimentare; realizzare vasche d’accumulo ed invasi di adeguate capacità a scopi principalmente irrigui e di salvaguardia idrogeologica.
“Si tratta di richieste, che partono dal territorio in assoluta sintonia con il nostro Piano Laghetti, la cui prima stesura prevede la realizzazione di 10 nuovi bacini in Piemonte per garantire l’irrigazione a quasi diciasettemila ettari in più, affiancandosi ai 4 invasi già operativi – ha indicato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI - Non solo: correlata a tali serbatoi è prevista la realizzazione di 14 impianti fotovoltaici galleggianti e 7 impianti idroelettrici per una produzione stimata in oltre trentadue milioni di kilowattora annui.”
L’Associazione Consorzi Irrigui Risorgive Mellea Centallese evidenzia inoltre, per la provincia di Cuneo, il drammatico problema dell’abbassamento della falda freatica e la crisi dei pozzi nati nei decenni scorsi per compensare la carenza delle acque superficiali per l’irrigazione.
“Di fronte alla crisi climatica la risposta – ha concluso Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI – non può che essere di sistema attraverso l’irrigazione collettiva che, grazie ad innovazione ed infrastrutturazione del territorio, ottimizzi l’uso della risorsa idrica, mantenendo non solo produttività, ma anche competitività all’agricoltura locale attraverso il contenimento dei costi sia energetici per il prelievo dell’acqua che manutentivi per il maggiore sforzo, cui sono la scarsità dei flussi idrici sottopone le pompe.”
OSSERVATORIO ANBI RISORSE IDRICHE
CRISI CLIMATICA: SICCITA’ E VIOLENTI TEMPORALI LOCALIZZATI SONO PROLOGHI DI UNA STAGIONE DALLE INCOGNITE ESTREME
CRESCE LO STRESS IDRICO IN CENTRO ITALIA
Se in Piemonte riappare lo spettro della siccità, altrove si registra un assaggio di quanto potrebbe succedere nei prossimi mesi meteorologicamente quantomai incerti e preoccupanti: nubifragi localizzati con celle temporalesche piccolissime, ma che comportano dannosi disagi alla popolazione con allagamenti e tetti scoperchiati; ad Ostia Lido, ad esempio, si sono rovesciati 68 millimetri di pioggia in sole 3 ore, ma poco o nulla è stato avvertito nelle zone limitrofe, così come a Civitanova Marche (mm. 44 in mezz’ora), Positano (mm. 57 in 5 ore) o a Pulfero, in provincia di Udine (mm. 85 in 3 ore).
“Di fronte all’estremizzazione degli eventi atmosferici su un territorio sempre più fragile ed in attesa di piani nazionali per la mitigazione degli effetti della crisi climatica, che rende inadeguata la rete idraulica del Paese, sono indispensabili campagne informative di prevenzione civile in territori sempre più alla mercè della violenza meteo” ha ribadito Francesco Vincenzi, Presidente ANBI.
.jpg) Nonostante le recenti piogge, quello 2023 rimane un autunno fortemente anomalo dopo un Settembre che, con + 2.17 gradi sulla media, risulta il terzo più caldo dal 1831 (fonte: CNR). Nei prossimi giorni, se al Centro e al Nord Italia sono previsti temporali e grandinate, al Sud le temperature dovrebbero superare i trenta gradi; in questo contesto resta molto alta la possibilità di pericolosi fenomeni estremi. Nel frattempo, il report settimanale dell’Osservatorio ANBI Risorse Idriche “fotografa” un Paese, dove i corpi idrici, soprattutto al Centro, sono sotto crescente stress. Al Nord i livelli dei grandi laghi sono in calo con il Lario ed il Sebino scesi sotto la media. In Valle d’Aosta cresce la Dora Baltea, mentre stazionaria è la portata del torrente Lys. I fiumi del Piemonte, fatta eccezione per la Varaita, continuano ad essere in sofferenza idrica: il record negativo è del Tanaro (-77% sulla media), dovuto al lungo periodo siccitoso vissuto dell’area meridionale della regione (fonte: ARPA Piemonte).
Nonostante le recenti piogge, quello 2023 rimane un autunno fortemente anomalo dopo un Settembre che, con + 2.17 gradi sulla media, risulta il terzo più caldo dal 1831 (fonte: CNR). Nei prossimi giorni, se al Centro e al Nord Italia sono previsti temporali e grandinate, al Sud le temperature dovrebbero superare i trenta gradi; in questo contesto resta molto alta la possibilità di pericolosi fenomeni estremi. Nel frattempo, il report settimanale dell’Osservatorio ANBI Risorse Idriche “fotografa” un Paese, dove i corpi idrici, soprattutto al Centro, sono sotto crescente stress. Al Nord i livelli dei grandi laghi sono in calo con il Lario ed il Sebino scesi sotto la media. In Valle d’Aosta cresce la Dora Baltea, mentre stazionaria è la portata del torrente Lys. I fiumi del Piemonte, fatta eccezione per la Varaita, continuano ad essere in sofferenza idrica: il record negativo è del Tanaro (-77% sulla media), dovuto al lungo periodo siccitoso vissuto dell’area meridionale della regione (fonte: ARPA Piemonte).
In Lombardia è stabile la portata del fiume Adda (circa centosessantasei metri cubi al secondo); le riserve idriche della regione continuano ad essere superiori alla media (+14,7%), grazie soprattutto al surplus d’acqua (+36%) negli invasi minori (fonte: ARPA Lombardia). In Veneto torna a decrescere il livello del fiume Adige; gli altri corsi d’acqua monitorati mantengono portate basse e solamente il Piave segna una performance positiva. In Emilia-Romagna solo il fiume Santerno è sopra la media, mentre permane la crisi dei corsi d’acqua nell’area occidentale della regione (Taro all’11% e Trebbia a poco più del 13% della portata media mensile); d’altronde è proprio nei bacini di questa macrozona, che il deficit pluviometrico si fa sentire maggiormente: nel bacino tra i fiumi Parma e Tidone, dove insiste la città di Piacenza, in 4 mesi sono caduti solo 100 millimetri di pioggia.
Nonostante tutto, aumenta leggermente la portata d’acqua lungo l’asta del fiume Po, che resta comunque largamente deficitario: ad Isola Sant’Antonio, in Piemonte, mancano oltre i 2/3 dei volumi che normalmente scorrono, mentre a Pontelagoscuro il gap è del 56% circa. In Liguria restano sostanzialmente invariati i livelli dei fiumi. In attesa delle piogge sono i fiumi ed i laghi del Centro Italia a soffrire maggiormente.
“Per noi – ha commentato Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI – la ricetta è sempre la stessa: infrastrutturazione del territorio ed innovazione per l’ottimizzazione d’uso della risorsa idrica. Il nostro Piano di Efficientamento della Rete Idraulica prevede nelle regioni centrali della Penisola investimenti per quasi seicentocinquantacinque milioni di euro, a fronte di 314 progetti capaci di garantire più di tremila posti di lavoro.”
In Toscana è sempre l’alveo del Serchio a registrare la performance peggiore con una portata, che si riduce di settimana in settimana e che al rilevamento di Ripafratta è del 42% inferiore a quella minima per il deflusso vitale e dell’84% sotto la media dello scorso quindicennio, ma addirittura segna -20% rispetto al 2022, anno di grave crisi per il fiume della Lucchesìa; anche l’Ombrone sta progressivamente scivolando verso il limite del deflusso vitale. Anche i livelli dei fiumi nelle Marche risultano stazionari (eccezioni: Tronto e Nera) e più bassi di quelli del recente passato. In Umbria continua ad abbassarsi il livello del lago Trasimeno (-cm.148 a fronte di un limite minimo di -cm.120), mentre cresce la Nera ed il Chiascio registra un’invarianza.
Come per il lago umbro, anche gli “specchi” di Bracciano e Nemi, nel Lazio, sembrano non uscire da un decennale periodo di crisi. Il bacino di Bracciano infatti ha perso ulteriori 4 centimetri, arrivando a toccare il livello idrometrico di -cm. 126, mentre quello di Nemi è ora addirittura 17 centimetri più basso dell’anno scorso. Leggera ripresa per il fiume Tevere, mentre invariati restano i livelli dell’Aniene e continua a registrare prestazioni positive la Fiora nel viterbese.
In Abruzzo, nonostante la prolungata siccità autunnale, nella diga di Penne sono ancora trattenuti 2.410.000 metri cubi d’acqua, valore nettamente superiore alla media del recente passato. In Basilicata, dove dopo molto tempo è tornata a farsi vedere la pioggia, anche localmente intensa, gli invasi sono calati di 14 milioni di metri cubi d’acqua in una settimana, mentre circa cinque milioni e mezzo sono i metri cubi distribuiti dai bacini di Puglia a testimonianza delle persistenti necessità irrigue delle campagne (12 mesi fa, invece, sulle regioni meridionali pioveva già parecchio).
In Sicilia, infine, nel mese di settembre, i bacini artificiali hanno erogato 35 milioni di metri cubi d’acqua e la risorsa idrica, attualmente trattenuta è complessivamente superiore alla media degli scorsi 13 anni.
EMILIA ROMAGNA: SODDISFATTE TUTTE LE RICHIESTE IRRIGUE
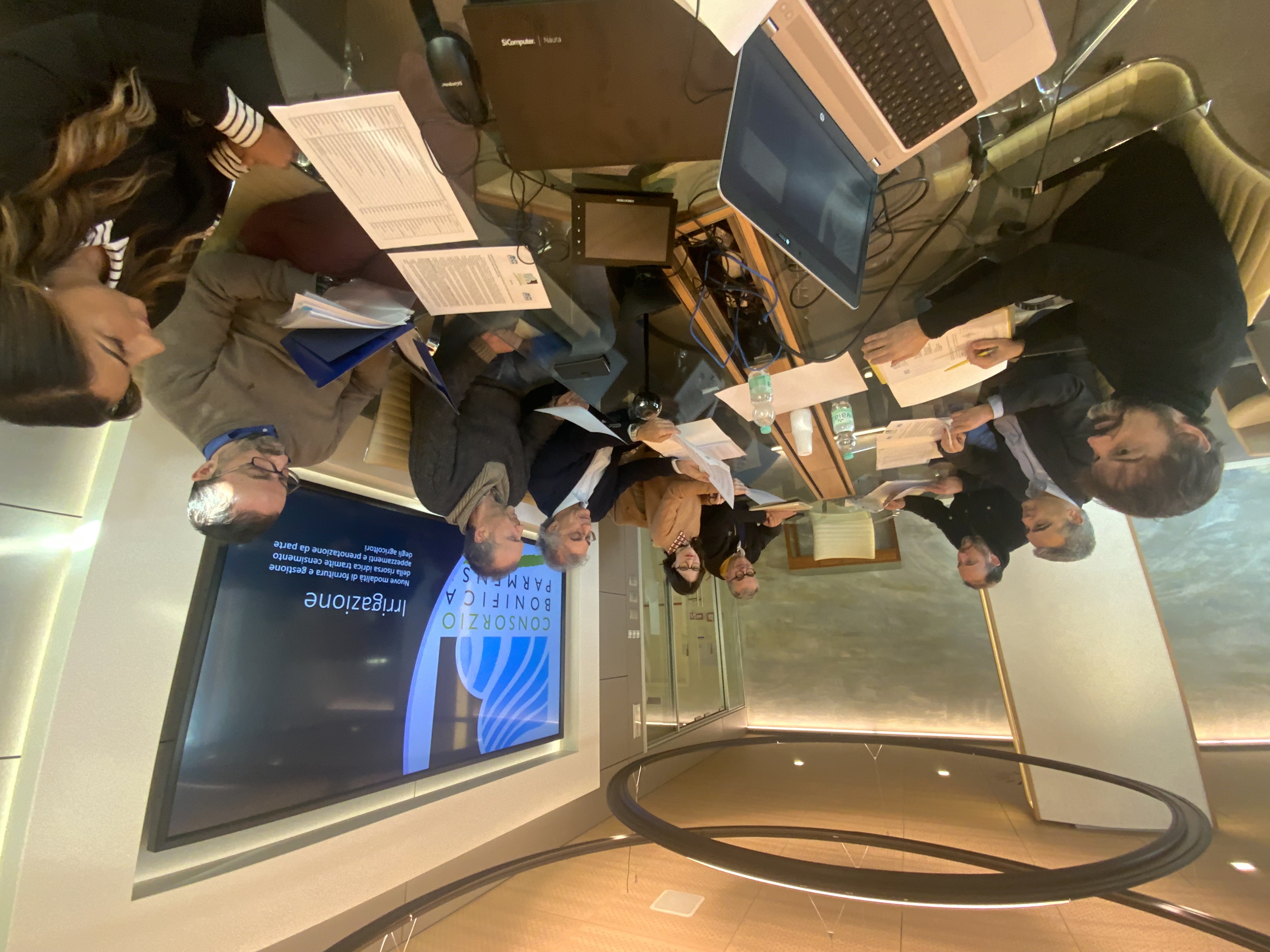 La richiesta irrigua è stata soddisfatta anche nella stagione 2023, con un totale di oltre millecento irrigazioni (per una quantità di risorsa erogata pari a 10 milioni di metri cubi) su circa cinquemila ettari agricoli serviti:
La richiesta irrigua è stata soddisfatta anche nella stagione 2023, con un totale di oltre millecento irrigazioni (per una quantità di risorsa erogata pari a 10 milioni di metri cubi) su circa cinquemila ettari agricoli serviti:
numeri tendenzialmente stabili rispetto ai valori della stagione scorsa, comunicati dal Consorzio di bonifica Parmense (con sede nella “città del Teatro Regio”) nel corso di un summit, svoltosi nella sede consortile della Casa dell'Acqua, a Parma, tra i vertici dell’ente di bonifica ed i rappresentanti delle associazioni agricole locali per condividere il bilancio dell'annata, il quadro operativo degli interventi eseguiti e quelli, che partiranno a breve.
La risorsa idrica nel Parmense arriva al mondo agricolo in via prioritaria, grazie ai prelievi realizzati mediante l’utilizzo di oltre venti impianti idrovori e 7 pozzi consortili che, attraverso una rete idrica consortile di oltre millecinquecento chilometri, hanno generato complessivamente una derivazione di acqua pari a 10 milioni di metri cubi.
Una percentuale di risorsa è stata disponibile mediante il prelievo da pozzo e da trattamento delle acque depurate dal servizio idrico IREN ed EmiliAmbiente.
VENETO: APPELLO AL TERRITORIO
Nelle recenti interlocuzioni tra Consorzio di bonifica Adige Po (con sede a Rovigo) ed i Sindaci del comprensorio, che interessa gran parte del Polesine, è emerso che ben 174 chilometri di sponde della rete idraulica consortile, articolata su 2.000 chilometri di canali, presentano rischi di frane ed erosioni non risolvibili tramite manutenzione ordinaria.
I problemi sono di varia natura e riguardano le caratteristiche dei terreni, i regimi idraulici, le infiltrazioni dell’acqua che ruscella dalle strade, l’intensificazione del traffico ed ovviamente l’azione delle nutrie. Per far fronte alle manutenzioni ordinarie, l’ente consortile mette a bilancio 300.000 euro, ma è consapevole che per risolvere questa problematica sono necessarie anche altre risorse e lancia, pertanto, un appello alle diverse realtà territoriali, a partire dalle amministrazioni che presiedono la viabilità arginale, con l’obbiettivo di raccogliere ulteriori fondi da investire in sicurezza.
L’ente consorziale ha chiesto alla Regione Veneto di finanziare 2 progetti, predisposti dai propri uffici tecnici, per l’importo di 3 milioni di euro ciascuno, finalizzati proprio alla sistemazione di numerosi tratti spondali franati. Ad oggi è stato finanziato uno stralcio funzionale dell’importo di € 1.100.000,00 che interessa i comuni di Loreo, Lendinara e Pettorazza Grimani.
Per far fronte a queste esigenze l’ “Adige Po”, in dialogo costante con le Amministrazione Locali, intende lanciare Accordi di Programma per la ricerca di finanziamenti dedicati e, nei casi più urgenti, per poter agire con fondi di bilancio, creando così sinergie sul territorio, finalizzate al raggiungimento di obbiettivi comuni.
TOSCANA: RIPRISTINATO REGOLARE FLUSSO IDRICO
(1).jpg) Continuano costanti gli interventi di manutenzione ordinaria nell’unità idrografica Albegna da parte del Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud (con sede a Grosseto), inseriti nel piano dell’attività della Bonifica.
Continuano costanti gli interventi di manutenzione ordinaria nell’unità idrografica Albegna da parte del Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud (con sede a Grosseto), inseriti nel piano dell’attività della Bonifica.
Sul fosso di Casale Nuovo a Marsiliana, nel comune di Manciano, l’ente consortile ha eseguito la decespugliazione meccanica della vegetazione infestante: così è stato ripristinato il regolare scorrimento delle acque verso valle, in modo da limitare i fenomeni di esondazione nelle aree adiacenti il corso d'acqua.
L’obiettivo è la tutela dal rischio idraulico delle abitazioni presenti a ridosso del fosso ed i ponti di attraversamento della strada vicinale, che collega i poderi della zona.
Il fosso scorre nella frazione Casale Nuovo in Marsiliana.
PUGLIA: MANUTENZIONE CONTINUA
Proseguono i lavori di efficientamento del canale collettore delle colline di Chieuti, finanziati nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 “Patto per la Puglia” e realizzati dal Consorzio di bonifica Capitanata (con sede a Foggia): si sta procedendo a riprofilatura, risezionamento e rivestimento in scogliera pesante del tronco del canale.
VENETO: PORTE VINCIANE CONTRO IL CUNEO SALINO
 Il Consorzio di bonifica Veneto Orientale (con sede a San Donà di Piave, in provincia di Venezia) ha portato a termine la manutenzione delle porte vinciane dello sbarramento irriguo sul canale Brian, nel territorio comunale di Eraclea.
Il Consorzio di bonifica Veneto Orientale (con sede a San Donà di Piave, in provincia di Venezia) ha portato a termine la manutenzione delle porte vinciane dello sbarramento irriguo sul canale Brian, nel territorio comunale di Eraclea.
I lavori sono consistiti nella riparazione della struttura metallica, nel cambio delle battute in legno e nella tinteggiatura delle porte; per il sollevamento e l'installazione delle strutture è stata impiegata una potente gru da 420 tonnellate. Ripristinata la sicurezza idraulica del manufatto, la seconda tranche dei lavori riguarderà la costruzione delle nuove paratoie dello sbarramento e l'implementazione dell’automazione e del telecontrollo.
Le porte di Brian rappresentano un manufatto idraulico, importantissimo per il sostegno della risorsa irrigua e la difesa dalla risalita del cuneo salino in un'area di ben 28.000 ettari, soggiacente al livello del mare. La prima struttura nell’area risale al 1870 mentre il sostegno, tutt’oggi in funzione, risale al 1931.
EMILIA ROMAGNA: CONCESSIONE DIGA BRUGNETO: INCONTRO SUL TERRITORIO PIACENTINO
Si è svolto nei giorni scorsi a Piacenza un incontro per discutere in merito all’imminente iter di rinnovo della concessione della diga del Brugneto; obbiettivo: la costruzione di un percorso, che veda il territorio piacentino più attivo e maggiormente incisivo in questa fase storicamente decisiva.
 Alla riunione, indetta dal locale Consorzio di bonifica Piacenza, sono stati invitati i Comuni piacentini, il cui territorio si affaccia sul fiume Trebbia, la Provincia di Piacenza, le associazioni datoriali del territorio piacentino, Legambiente Piacenza, i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia Occidentale (Parchi del Ducato) ed i consiglieri regionali piacentini.
Alla riunione, indetta dal locale Consorzio di bonifica Piacenza, sono stati invitati i Comuni piacentini, il cui territorio si affaccia sul fiume Trebbia, la Provincia di Piacenza, le associazioni datoriali del territorio piacentino, Legambiente Piacenza, i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia Occidentale (Parchi del Ducato) ed i consiglieri regionali piacentini.
In forza di un provvedimento ministeriale ed in conformità al disciplinare di concessione, dalla diga del Brugneto annualmente vengono rilasciati 2.500.000 metri cubi d’acqua a favore delle utenze irrigue piacentine. Nell’ultimo decennio si è per altro aperta una nuova stagione, in cui non è più stata una barriera, quella di eventuali rilasci aggiuntivi, concordati sulla base di una serie di condizioni come, ad esempio, il riempimento dell’invaso o le crisi idriche. La diga del Brugneto, situata in comune di Torriglia nella provincia di Genova, sbarra il torrente omonimo, creando un bacino artificiale; l’utilizzo della risorsa idrica interessa Emilia Romagna e Liguria.
La procedura di rinnovo della concessione di derivazione, che dovrebbe partire nel 2024, è di competenza ministeriale e la Regione Emilia Romagna sarà chiamata a portare le sue valutazioni in sede di conferenza dei servizi.
Dall’incontro è emersa coesione e la volontà di fare fronte comune per portare avanti gli interessi territoriali. Verrà ora redatto un documento, a firma congiunta, di supporto a quelle, che sono le istanze del territorio da presentare alla Regione Emilia Romagna, che è il soggetto titolato in materia. L’obbiettivo dell’ente consortile è quello di avere una dotazione supplementare dalla diga del Brugneto, qualora fossero disponibili le quantità, perché l’acqua rimane l’elemento fondamentale per il sistema agroalimentare, ma anche per l’ambiente, la biodiversità ed il turismo della valle.
TOSCANA: TUTTO LED
 Si è conclusa la sostituzione totale dei 593 punti luce dislocati nelle sedi e negli impianti idrovori del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord (con sede a Viareggio, in provincia di Lucca): un lavoro che, grazie alla progressiva eliminazione delle lampade tradizionali in favore di quelle a LED, ha permesso di ottimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica, grazie anche all’ausilio di sistemi crepuscolari e riduttori di intensità automatici per gli ambienti esterni.
Si è conclusa la sostituzione totale dei 593 punti luce dislocati nelle sedi e negli impianti idrovori del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord (con sede a Viareggio, in provincia di Lucca): un lavoro che, grazie alla progressiva eliminazione delle lampade tradizionali in favore di quelle a LED, ha permesso di ottimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica, grazie anche all’ausilio di sistemi crepuscolari e riduttori di intensità automatici per gli ambienti esterni.
Si tratta di un percorso di efficientamento energetico, avviato 4 anni fa e che ha portato a ridurre i consumi di energia di 70.000 kilowattora all’anno con vantaggi economici, ma anche ecologici, perché il minor consumo di energia si traduce in una diminuzione immediata di CO2, pari a 38 tonnellate annue, che non vengono emesse in atmosfera.
I risparmi sul bilancioi saranno impiegati per maggiori lavori di manutenzione e quindi per accrescere la sicurezza dal rischio idrogeologico.
VILLAGGIO COLDIRETTI: UNA PRESENZA CHE GUARDA AL FUTURO
E’ stata l’innovazione, il filo conduttore delle iniziative ANBI all’interno del Villaggio Coldiretti, svoltosi a Roma. A fare la parte del leone è stata la firma dell’accordo ANBI – Consorzio C.E.R. Canale Emiliano Romagnolo (con sede a Bologna) - BF SpA, il più grande gruppo agricolo italiano, per lo sviluppo del sistema irriguo “esperto” Irriframe.
 L’implementazione del software sarà affidato alla società IBF, mentre l’ente consortile di 2° grado (con sede a Bologna) si occuperà delle verifiche in campo, lasciando ad ANBI la promozione e diffusione del prodotto per l’ottimizzazione d’uso della risorsa idrica in agricoltura. Dell’importanza dello sviluppo tecnologico si è parlato anche nei 2 eventi sul tema “I Consorzi di bonifica protagonisti per le politiche di contrasto al rischio idrogeologico e per l’innovazione nell’uso multifunzionale dell’acqua”, realizzati con la partnership di imprese, quali CAE ed Energreen.
L’implementazione del software sarà affidato alla società IBF, mentre l’ente consortile di 2° grado (con sede a Bologna) si occuperà delle verifiche in campo, lasciando ad ANBI la promozione e diffusione del prodotto per l’ottimizzazione d’uso della risorsa idrica in agricoltura. Dell’importanza dello sviluppo tecnologico si è parlato anche nei 2 eventi sul tema “I Consorzi di bonifica protagonisti per le politiche di contrasto al rischio idrogeologico e per l’innovazione nell’uso multifunzionale dell’acqua”, realizzati con la partnership di imprese, quali CAE ed Energreen.
Fra le presenze allo stand vanno segnalate quelle del Presidente Commissione Agricoltura Senato, Luca De Carlo e del Vicepresidente Commissione Ambiente Camera, Battistoni, nonché del Segretario Autorità Bacino Distrettuale Appennino Centrale, Marco Casini. Durante la kermesse del Villaggio Coldiretti si è tenuto anche l’incontro “Bonifiche nel Lazio con ANBI Lazio”. Ad aprire i lavori è stato il Presidente Coldiretti Lazio, David Granieri, che ha evidenziato come sia prossima alla conclusione, la riforma dei Consorzi di bonifica avviata nel 2015 e che ridurrà il numero di tali enti da 10 a 4, trasmettendo un'immagine di rinnovata efficienza e virtuosità.
Presente anche la Presidente di ANBI Lazio, Sonia Ricci, che ha indicato come sia necessario continuare a programmare nuove progettualità, affinché la prevenzione prenda il posto dell’emergenza. Il Presidente del Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest (con sede a Latina), Lino Conti, ha illustrato il progetto “Eufente-Selcella-Pio VI”, finanziato grazie al MASAF e che aumenterà la portata idrica annuale di 7 milioni di metri cubi, evitando la dispersione di preziosa risorsa idrica nel mare a favore dell’agricoltura. A concludere i lavori è stato l’Assessore Bilancio, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Parchi e Foreste di Regione Lazio, Giancarlo Righini, che ha tra l’altro sottolineato come la Regione Lazio veda nella realizzazione di nuovi invasi artificiali, una concreta risposta alla siccità ed ai cambiamenti climatici.
Il Direttore Generale Consorzio di bonifica Litorale Nord (con sede a Roma), Andrea Renna, ha sottolineato con forza l'importanza di concretizzare un "patto per il suolo insieme a quello per l’acqua"; in questo contesto è fondamentale la sinergia con Regione Lazio e Sindaci per tradursi in azioni concrete a beneficio della comunità.
Direttore Responsabile: Massimo Gargano - Registrazione Tribunale di Roma n. 559/98 del 25 novembre 1998
Redazione: Via S.Teresa, 23 - 00198 Roma - Tel. 06/844321 - Fax 06/85863616
Sito internet: anbi.it - eMail: anbimail@tin.it