
MARTEDI WORKSHOP A ROMA SU “DEFLUSSO ECOLOGICO, OSSERVATORIO ANBI, FUTURO CLIMATICO”
A fronte dei molteplici riflessi, che la criticità idrica sta avendo per il nostro Paese e dell’evidente necessità di urgenti interventi infrastrutturali, l’Associazione Nazionale Consorzi Gestione Territorio e Tutela Risorse Idriche promuove un confronto con il mondo della politica a partire dai dati dell’Osservatorio ANBI Risorse Idriche e con l’ausilio degli scenari proposti dal meteorologo, Paolo Sottocorona.
Il workshop si terrà martedì 14 Giugno p.v., dalle ore 11.00, nella Sala Medici della sede ANBI, a Roma (in via Santa Teresa, 23).
Con il Presidente ANBI, Francesco Vincenzi, interverranno il Presidente, Gianpaolo Vallardi ed i componenti della Commissione Agricoltura del Senato, Mino Taricco e Giorgio Maria Bergesio; il Presidente, Filippo Gallinella ed i componenti della Commissione Agricoltura della Camera, Giuseppe L’Abbate e Raffaele Nevi.
A coordinare l’incontro sarà il Direttore Generale ANBI, Massimo Gargano.
OSSERVATORIO ANBI RISORSE IDRICHE
E’ ALLARME SUL DELTA PO ORMAI SALATO: INIZIATA LA SOSPENSIONE DELLE IRRIGAZIONI E’ CRISI IDRICA SUI CASTELLI ROMANI, MENTRE AL NORD RITORNA L’EMERGENZA IDROGEOLOGICA
L’Osservatorio ANBI Risorse Idriche ha reso noto che supera ormai i quindici chilometri, la risalita del cuneo salino lungo il fiume Po, che al rilevamento di Pontelagoscuro è sceso al di sotto dei minimi storici, toccando i 301,6 metri cubi al secondo, molto al di sotto della soglia critica, fissata a mc/sec 450. Ciò ha già costretto a sospendere l’irrigazione in alcune zone di Porto Tolle ed Ariano, nel Polesine rodigino, dove sono state attivate pompe mobili d’emergenza per garantire la sopravvivenza delle colture.
“E’ un fenomeno invisibile, ma che sta sconvolgendo l’equilibrio ambientale del delta polesano – ha commentato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI – Se la situazione persisterà, entro la settimana prossima saranno contaminate le prime falde destinate all’uso potabile.”
Molto grave è la situazione idrica anche nel resto del Veneto, dove tutti i corsi d’acqua, ad eccezione del Bacchiglione, registrano decrescite vertiginose: il bollettino pluviometrico regionale segnala come, a Maggio, il deficit sia stato del 46%, mentre in alcuni bacini si sia arrivati addirittura ad oltre il 70% (Lemene -77%, Pianura tra Livenza e Piave – 73%) o poco meno (Tagliamento -67%, Sile -61%); l’indice SPI (Standardized Precipitation Index) annuale certifica una regione in larga parte colpita da estrema siccità. Il secondo fiume italiano, l’Adige, ad esempio, alla stazione di Boara Pisani segna un livello idrometrico, inferiore di oltre m. 2,20 a quello dell’anno scorso e di circa un metro rispetto al 2017. “Catastrofica” viene altresì definita la situazione idrica ai Castelli Romani, dove i laghi sono ai minimi storici con deficit idrico quantificabile in 50 milioni di metri cubi: il bacino di Nemi ha un livello medio (cm. 50), inferiore di oltre un metro a quello registrato nello stesso periodo dell’anno scorso (cm. 162)!
 “In queste zone – ha precisato Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI – le conseguenze dei cambiamenti climatici si sommano ad un’eccessiva pressione antropica, maturata negli anni ed i cui prelievi idrici hanno abbassato la falda a livelli tali da rendere ormai impossibile la ricarica degli specchi lacustri, le cui acque altresì sono richiamate nel sottosuolo.”
“In queste zone – ha precisato Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI – le conseguenze dei cambiamenti climatici si sommano ad un’eccessiva pressione antropica, maturata negli anni ed i cui prelievi idrici hanno abbassato la falda a livelli tali da rendere ormai impossibile la ricarica degli specchi lacustri, le cui acque altresì sono richiamate nel sottosuolo.”
Rimanendo nel Lazio, anche le altezze idrometriche del fiume Tevere sono inferiori a quelle delle annualità precedenti e livelli minimi si registrano anche per Sacco ed Aniene. La più volte evidenziata “tropicalizzazione” del clima ha, per estremo contrappasso, registrato dannosi episodi di maltempo con conseguente dissesto idrogeologico in Veneto (nelle province di Belluno, Vicenza, Verona) e Trentino Alto Adige (a Predazzo, in val Ridanna, Bassa Pusteria, Val di Non e nell’Alta Valle dell’Isarco), ma anche in Lombardia (a Casalzuigno, nel Varesotto, sono caduti 70 millimetri di pioggia in pochi minuti).
Ciò nonostante, calano i livelli dei laghi d’Iseo e di Como, così come del Maggiore, che è ormai a pochi centimetri dal minimo storico. In Valle d’Aosta cala il torrente Lys ed anche la Dora Baltea ha portate inferiori agli anni scorsi. Esemplare è l’analisi dell’indice semestrale SPI sul Piemonte: indica una condizione di siccità estrema su circa il 90% della regione, dove il bollettino pluviometrico di Maggio segnala un deficit pari al 23,4% con punta record del 60,9% nel bacino dell’Agogna-Terdoppio (52,4% nel Cervo e il 49,1 nell’Orba); in questo quadro si evidenziano i cali di portata nel Tanaro e nella Stura di Demonte.
Nel NordOvest, a beneficiare delle recenti, quanto violente piogge, pare essere stato il fiume Adda, che registra un aumento di portata, pur rimanendo ai livelli più bassi in anni recenti. Rimane, al contempo, molto grave la situazione delle riserve idriche della Lombardia, dove la neve è già quasi completamente sciolta (l’82% in meno rispetto alla media storica, ma anche -90% in meno rispetto ad un 2021 già caratterizzato dalla carenza d’acqua): d’ora in avanti si potrà fare affidamento solo sulle precipitazioni, avendo poca acqua stoccata nei bacini e niente neve sui monti.
In Emilia Romagna, dove il 50% del territorio presenta un bilancio idro-climatico da bollino rosso, le portate dei fiumi continuano inesorabilmente a calare con il Reno, che scende sotto i minimi storici e l’unico corso d’acqua, che si possa definire “in salute” è il Panaro. Il quadro idrico complessivo è tutt’altro che roseo e, in assenza di significative precipitazioni, metterà a repentaglio la continuità del prelievo di livelli costanti d’acqua indispensabile all’agricoltura, delineando uno scenario simile a quello dell’estate più inoltrata. Sulla Toscana, a Maggio, le piogge sono state dal 50% al 70% in meno rispetto alla media storica (mm.29 invece di mm.71) con record negativi sui bacini dei fiumi Fiora ed Ombrone sud-orientale (sono caduti mm. 19 ca.); l’Arno scende ad una portata di mc/sec 7,83 mc/s ed anche il Serchio vede una portata più che dimezzata rispetto alla scorsa settimana.
Nelle Marche, l’estate si prospetta complessa come quella dell’anno scorso, in quanto i livelli dei fiumi stanno continuando a decrescere in maniera consistente: il Sentino è solo 5 centimetri al di sopra del minimo storico, che l’anno scorso era stato toccato soltanto alla fine di Agosto. Resta confortante la situazione negli invasi, che continuano a contenere circa 4 milioni di metri cubi d’acqua di più dell’anno scorso.
È difficile la situazione idrica anche in Umbria: il lago Trasimeno segna il livello più basso dal Maggio 2003; nella Bassa Valle del Tevere, il “fiume di Roma”, a Maggio ha registrato la media mensile più bassa dal ’96; i volumi della diga Maroggia sono ai minimi del recente quadriennio. In controtendenza è invece l’Abruzzo dove , nonostante le scarse precipitazioni del mese scorso, l’invaso della diga di Penne registra il record d’acqua invasata dal 2017.
In Campania, il rischio di siccità permane nei bacini dei fiumi Garigliano e Volturno, i cui livelli idrometrici si presentano in netto calo, ma ormai lambisce anche quello del Sele, la cui portata è in lieve flessione come quella del Sarno; inoltre, si segnalano in deciso calo i volumi dei bacini del Cilento e del lago di Conza . In Basilicata, dove a Maggio sono caduti circa quarantacinque millimetri di pioggia, i livelli medi del fiume Agri sono più bassi rispetto agli anni precedenti e dai bacini artificiali è attinto 1 milione di metri cubi d’acqua al giorno.
Più cospicui sono i prelievi dagli invasi della Puglia, dove in una settimana sono stati utilizzati circa undici milioni di metri cubi di risorsa idrica. In Sardegna, infine, è definito un “livello di pericolo” per i serbatoi appartenenti ai sistemi idrici Nord-Occidentale, Alto Cixerri, Alto Coghinas; buone invece le performances registrate nei bacini appartenenti ai sistemi idrici di Gallura e Tirso-Flumendosa.

EMILIA ROMAGNA : LA SICCITA’ NON MOLLA
 Le stazioni di registrazione dei livelli del fiume Po rimangono ancorate allo stato di siccità grave e proprio il Grande Fiume, attraverso il canale C.E.R. è la principale ed essenziale fonte di approvvigionamento della quasi totalità delle colture tipiche della Romagna e di parte dell’Emilia Orientale; una riduzione drastica dei prelievi di risorsa idrica e conseguente derivazione irrigua significherebbero un incalcolabile danno per quei territori.
Le stazioni di registrazione dei livelli del fiume Po rimangono ancorate allo stato di siccità grave e proprio il Grande Fiume, attraverso il canale C.E.R. è la principale ed essenziale fonte di approvvigionamento della quasi totalità delle colture tipiche della Romagna e di parte dell’Emilia Orientale; una riduzione drastica dei prelievi di risorsa idrica e conseguente derivazione irrigua significherebbero un incalcolabile danno per quei territori.
Il quadro idrico complessivo è tutt’altro che roseo, delineando uno scenario del tutto simile a quello tipico dell’estate più inoltrata. La situazione fa sì che, sulla base delle stime dei fabbisogni irrigui consigliati agli imprenditori agricoli dal sistema intelligente IRRIFRAME - ANBI, il Consorzio di 2° grado C.E.R.- Canale Emiliano Romagnolo (con sede a Bologna) debba innalzare i livelli del proprio sistema idrico, fornendo precise indicazioni sulla possibilità di riduzione delle restituzioni idriche; avendo raggiunto uno scenario di prima attenzione, tutti gli associati sono dunque invitati ad attuare le proprie misure di adattamento per mitigare l'incidenza della siccità.
In questa fase, invece, non si sono verificate criticità per quanto riguarda il bacino del fiume Reno.
OSSERVATORIO ANBI RISORSE IDRICHE
NON SOLO ITALIA: LA GRANDE SETE CHE VA DALL’AFRICA AL MEDITERRANEO E COSTA 9 MILIARDI ANNUI ALL’EUROPA
“La sola ipotesi che la strage nella chiesa cattolica in Nigeria rientri all’interno di un conflitto locale per il controllo delle risorse idriche, in una condizione di crescente desertificazione a seguito dei cambiamenti climatici, è un ulteriore campanello d’allarme su uno scenario, da cui nessuno può chiamarsi fuori”: a dirlo è stato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI, da anni impegnata a vari livelli anche in progetti di “solidarietà idrica” con Paesi del Terzo Mondo. E’ drammatica, infatti, la situazione nel continente africano, dove siccità e carestia sono diventati fenomeni endemici in diversi Paesi, in cui la disponibilità d’acqua è calata del 30% nel recente triennio (nel solo Corno d’Africa sono morti 3 milioni di capi di bestiame); i dati dell’OCHA (Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari) indicano che circa quaranta milioni di persone sono sotto la soglia di sopravvivenza tra Somalia, Etiopia, Kenia, Burkina Faso, Ciad, Niger, Mali e Nigeria; ad aggravare tale situazione c’è il blocco delle esportazioni di grano, dovuto alla guerra fra Russia ed Ucraina. In Marocco, le dighe a maggio contenevano soltanto il 30% della capacità contro il 70% di due anni fa.
 “I dati riportati – ha aggiunto il Presidente ANBI – non solo testimoniano una catastrofe umanitaria, ma fanno chiarezza sui perché dei grandi flussi migratori e che, stante l’attuale andamento climatico, saranno inevitabili.”
“I dati riportati – ha aggiunto il Presidente ANBI – non solo testimoniano una catastrofe umanitaria, ma fanno chiarezza sui perché dei grandi flussi migratori e che, stante l’attuale andamento climatico, saranno inevitabili.”
In Europa, la siccità non colpisce pesantemente solo l’Italia, ma l’intera area mediterranea, dove sempre più scarse sono anche le riserve d’acqua nei serbatoi sotterranei: ad evidenziarlo è stato l’Osservatorio ANBI Risorse Idriche all’indomani della Giornata Mondiale dell’Ambiente. Nella vicina Francia, il deficit idrologico 2021-2022 è stato, fino ad Aprile, pari al 20% con punte di -40% a Febbraio e Marzo; come in Italia, pochissima è stata la neve caduta in inverno e, nel mese di maggio, in diverse località le temperature massime sono state da 5 a 7 gradi superiori alle medie storiche, segnando record a Strasburgo 34,6°, Albi 35,4°, Tarbes 34,1°.
In Spagna, le abbondanti piogge cadute tra Marzo ed Aprile hanno in parte riequilibrato gli effetti di un inverno tra i più secchi di sempre ma, nonostante questo, l’acqua accumulata a Maggio nei serbatoi è solo il 48% della capacità d’invaso (-28% sulla media del periodo).
Secondo la Commissione Europea, le conseguenze della siccità (dalla mancata produzione agricola all’aumento dei costi irrigui) stanno costando all’area, che comprende Unione Europea e Gran Bretagna, circa nove miliardi di euro all’anno, con punte di 1 miliardo e mezzo in Spagna e di 1 miliardo e 400 milioni in Italia. In assenza di azioni per contrastare il cambiamento climatico, con un aumento della temperatura di 3 gradi, nel 2100 il costo sarebbe quintuplicato (45 miliardi) e balzerebbe a 65 miliardi, se il termometro crescesse di un ulteriore grado. Per l’Italia si stimano danni tra i 5,4 e gli 8,9 miliardi annui.
“Di fronte a questi dati ed in attesa di interventi planetari di contrasto ai cambiamenti climatici, ancora lungi dall’essere attuati e comunque realizzabili solo nel lungo periodo, anche in Italia sono indispensabili politiche di adattamento infrastrutturali come la realizzazione di nuovi bacini e reti idriche, capaci di incrementare la resilienza dei territori – ha indicato Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI - I Consorzi di bonifica ed irrigazione hanno un ampio parco progetti a servizio del Paese; alla politica chiediamo le opportune scelte per la loro realizzazione.”
VENETO: INAUGURATO NUOVO IMPIANTO PLUVIRRIGUO
Alla presenza del Sottosegretario Politiche Agricole Alimentari Forestali, Francesco Battistoni, il Consorzio di bonifica Veronese (con sede nella città scaligera) ha inaugurato l’impianto pluvirriguo Coronini a Villafranca di Verona e che consentirà un risparmio fino al 50% di risorsa irrigua su 500 ettari di area pedecollinare, coltivata a vigneti (apprezzate D.O.C. come Custoza e Bardolino), seminativi ed alberi da frutto.
L’intervento è il primo di una progettualità più ampia, avviata dall’ente consortile e che include anche la riconversione irrigua, da scorrimento a pressione, nei comuni di Sona (località Palazzolo) ed Oppeano (località Ca’ degli Oppi), il cui valore complessivo ammonta a 20 milioni di euro finanziati dal Mi.P.A.A.F.(Piano Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020). Una volta ultimati gli interventi, la rete in pressione nel comprensorio di bonifica del “Veronese” aumenterà di km. 160, passando da 830 a 990 chilometri, mentre la superficie agricola irrigata “a pressione” aumenterà di 1.800 ettari (da ha. 9.060 a ha. 10.860) per un risparmio di risorsa del 50% in tutta l’area infrastruttura.
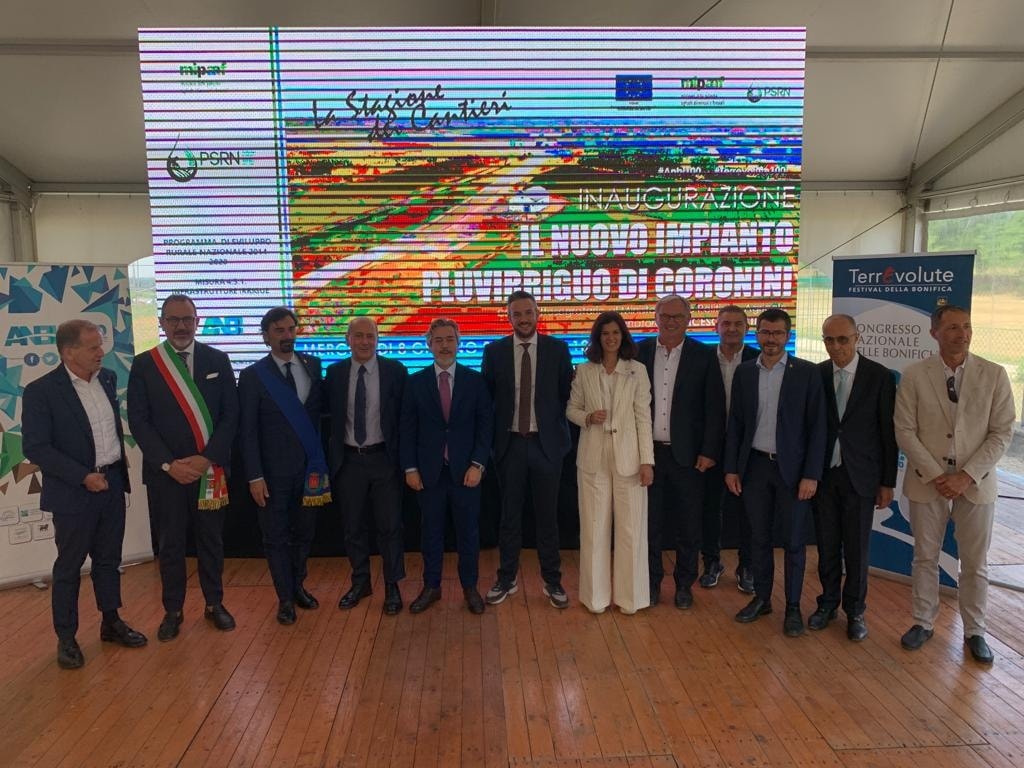 Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti anche la Vicepresidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, Roberta Toffanin ed il Direttore Generale ANBI, Massimo Gargano, oltre naturalmente ai vertici dell’ente consortile ospite (Alex Vantini, Presidente e Roberto Bin, Direttore), di ANBI Veneto (il Presidente, Francesco Cazzaro) ed ai rappresentanti delle Istituzioni del territorio. L’inaugurazione si inseriva nel contesto degli eventi per “Terrevolute 100” e de “La stagione dei Cantieri” dei Consorzi di bonifica del Veneto. Complessivamente, infatti, gli enti consortili veneti sono riusciti ad attrarre 85 milioni di euro dal P.S.R.N. 2014-2020 per 11 progetti di efficientamento della distribuzione irrigua, che si sommano ad altri 3 importanti interventi ad opera del Consorzio di bonifica Adige Euganeo con sede ad Este nel padovano (46 milioni di euro), del Consorzio di bonifica Brenta con sede a Cittadella in provincia di Padova (12 milioni di euro) ed ancora dell’ente consortile Veronese (12 milioni di euro).
Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti anche la Vicepresidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, Roberta Toffanin ed il Direttore Generale ANBI, Massimo Gargano, oltre naturalmente ai vertici dell’ente consortile ospite (Alex Vantini, Presidente e Roberto Bin, Direttore), di ANBI Veneto (il Presidente, Francesco Cazzaro) ed ai rappresentanti delle Istituzioni del territorio. L’inaugurazione si inseriva nel contesto degli eventi per “Terrevolute 100” e de “La stagione dei Cantieri” dei Consorzi di bonifica del Veneto. Complessivamente, infatti, gli enti consortili veneti sono riusciti ad attrarre 85 milioni di euro dal P.S.R.N. 2014-2020 per 11 progetti di efficientamento della distribuzione irrigua, che si sommano ad altri 3 importanti interventi ad opera del Consorzio di bonifica Adige Euganeo con sede ad Este nel padovano (46 milioni di euro), del Consorzio di bonifica Brenta con sede a Cittadella in provincia di Padova (12 milioni di euro) ed ancora dell’ente consortile Veronese (12 milioni di euro).
Con un investimento complessivo, che supera i centocinquantacinque milioni di euro, oltre al recupero ed al miglioramento della capacità di invaso di vasta parte della rete idraulica consortile, saranno riconvertiti ha. 15.000 da irrigazione “a scorrimento” ad “irrigazione a pressione”, aggiungendosi ai 40.000 ettari già presenti.
Nel processo di efficientamento della rete irrigua, grande importanza avrà anche il P.N.R.R. (Piano Nazionale Ripresa Resilienza), per il quale i Consorzi di bonifica veneti concorrono con 21 progetti per un totale di circa duecentoventicinque milioni di euro; a questi si aggiungono 13 progetti per 100 milioni di euro, che attendono di essere finanziati tramite Legge 178/2020.
PUGLIA: RIUSIAMO: DARE NUOVA VITA ALL’ACQUA
 Nell’ambito del progetto ”Distretti irrigui per il riuso sostenibile delle acque reflue: modelli organizzativi e tecnologie innovative- RIUSIAMO”, finanziato con fondi P.S.R. (Piano Sviluppo Rurale) Puglia 2014-2020, il Consorzio di bonifica Capitanata (con sede a Foggia) ha promosso un meeting tecnico-divulgativo con gli stakeholders territoriali.
Nell’ambito del progetto ”Distretti irrigui per il riuso sostenibile delle acque reflue: modelli organizzativi e tecnologie innovative- RIUSIAMO”, finanziato con fondi P.S.R. (Piano Sviluppo Rurale) Puglia 2014-2020, il Consorzio di bonifica Capitanata (con sede a Foggia) ha promosso un meeting tecnico-divulgativo con gli stakeholders territoriali.
L’evento ha avuto inizio presso l’impianto di affinamento reflui di Trinitapoli per continuare presso la vasca di stoccaggio reflui n.17, in località Castello.
Il gruppo si è quindi trasferito all’ufficio irriguo 5-9-10 della Sinistra Ofanto in località San Samuele in agro di San Ferdinando di Puglia per la visita all’impianto irriguo. Il progetto RIUSIAMO nasce dall’esigenza di rendere disponibile ed utilizzare la “nuova” risorsa, rappresentata dalle acque reflue, attraverso la costituzione di “distretti irrigui ad hoc”, mediante un’azione congiunta realizzata con vari attori della filiera.
Il progetto prevede sia il monitoraggio delle acque, sia la pianificazione della distribuzione, che darà agli agricoltori elementi utili a gestire le loro strategie irrigue: è quindi un lavoro coordinato, che coinvolge i gestori del servizio e gli agricoltori, ma anche enti di ricerca ed aziende tecnologiche.
BOLOGNA, PARADIGMA D’ITALIA:
NOMISMA CALCOLA IL VALORE ECONOMICO DEI SERVIZI AMBIENTALI SVOLTI DALL’IRRIGAZIONE
E’ l’autorevole istituto di ricerca Nomisma ad attestare il valore anche economico dei servizi complementari, svolti dall’irrigazione per l’ambiente: un suo studio, presentato recentemente a Bologna, stima, in almeno 2.700.000 euro, i benefici ecosistemici apportati al territorio felsineo, dove il Consorzio di bonifica Renana irriga circa ventimila ettari; si tratta del 25% dei suoli coltivati e potenzialmente irrigui nel locale bacino del fiume Reno, dove il valore economico dell’agricoltura “bagnata” è stimato in 18.900.000 euro, cioè ben il 40% del valore complessivo della produzione primaria del territorio.
.jpg) “Il lavoro, che ha sperimentato un metodo di valutazione economica dei servizi ecosistemici – ha precisato Marco Marcatili, Responsabile Sviluppo e Sostenibilità Nomisma – dimostra come i 4 milioni di euro, investiti dal Consorzio di bonifica Renana per l’irrigazione, generano almeno 2.700.000 euro in termini di benefici multipli, quali biodiversità, habitat, paesaggio per tutta la collettività bolognese.”
“Il lavoro, che ha sperimentato un metodo di valutazione economica dei servizi ecosistemici – ha precisato Marco Marcatili, Responsabile Sviluppo e Sostenibilità Nomisma – dimostra come i 4 milioni di euro, investiti dal Consorzio di bonifica Renana per l’irrigazione, generano almeno 2.700.000 euro in termini di benefici multipli, quali biodiversità, habitat, paesaggio per tutta la collettività bolognese.”
“L’attestazione di un accreditato istituto di ricerca è quantomai importante, perchè c’è ancora scarsa consapevolezza sul legame tra attività irrigua e benefici ambientali – ha commentato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI – Per superare questo gap vanno segnalate la crescente diffusione dei bilanci ambientali fra i Consorzi di bonifica ed irrigazione, nonchè la certificazione Goccia Verde, voluta da ANBI per attestare la sostenibilità idrica delle produzioni agroalimentari.”
Tra i benefici ambientali dovuti all’agricoltura irrigua ci sono la ricarica diffusa delle falde freatiche ed il ritorno della risorsa idrica nel ciclo naturale, ma anche la fitodepurazione, il contrasto alla subsidenza , la regolazione del microclima locale e la riduzione dell’effetto “isola di calore”, la conservazione del paesaggio rurale storico e la permanenza delle colture irrigue tradizionali.
Specifica Paolo Pini, Direttore Consorzio di bonifica Renana: “Degli 80 milioni di metri cubi di acqua, distribuiti dal reticolo idraulico consortile, l’85% è derivato dal fiume Po attraverso il Canale Emiliano Romagnolo; almeno 35 milioni di metri cubi di risorsa idrica sono fruiti direttamente dagli ecosistemi e dalle zone umide, connessi al reticolo dei canali irrigui.”
“Nell’area metropolitana bolognese – ha aggiunto Valentina Borghi, Presidente dell’ente consortile - ci sono 2.500 ettari destinati a valle o area umida, la cui biodiversità è garantita dal mantenimento di adeguati livelli idrici, nonostante la siccità in annate come questa. Si tratta, quindi, di una funzione ambientale svolta direttamente dal sistema irriguo consortile.”
“Lo studio di Nomisma – ha concluso Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI – conferma che senza acqua e quindi irrigazione non solo non può esserci agricoltura, ma muore pure la natura. Da qui, la necessità di incrementare le riserve idriche attraverso la realizzazione di invasi multifunzionali come i 10.000, in collina e pianura, previsti dal Piano Laghetti proposto insieme a Coldiretti.”
TOSCANA: 100 ANNI DI MODERNA BONIFICA: CONVEGNO A FIRENZE
Anche a Firenze, nello stupendo Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, si sono celebrati i 100 anni della Bonifica moderna; promosso da ANBI Toscana, l’evento “1922-2022: la Bonifica per la sostenibilità” ha permesso di fare il punto su quanto fatto e aprire una riflessione sull’impegno futuro fra sicurezza, sostenibilità, ambiente e agricoltura.
 L’appuntamento è arrivato all’indomani della Giornata delle Manutenzioni, promossa da ANBI Toscana con la Regione, dedicata a tracciare il bilancio degli investimenti e dei relativi risultati delle attività di bonifica, che hanno dato vita ad un vero e proprio “modello toscano”. Nel 2021 sono stati quasi centoventuno i milioni di euro investiti per tenere in sicurezza oltre trentaseimila chilometri di corsi d’acqua: 6,5 milioni arrivano dalla Regione Toscana; 92 milioni da fondi derivanti dal tributo di bonifica 2021 ed altri 23milioni da investimenti extra tributo.
L’appuntamento è arrivato all’indomani della Giornata delle Manutenzioni, promossa da ANBI Toscana con la Regione, dedicata a tracciare il bilancio degli investimenti e dei relativi risultati delle attività di bonifica, che hanno dato vita ad un vero e proprio “modello toscano”. Nel 2021 sono stati quasi centoventuno i milioni di euro investiti per tenere in sicurezza oltre trentaseimila chilometri di corsi d’acqua: 6,5 milioni arrivano dalla Regione Toscana; 92 milioni da fondi derivanti dal tributo di bonifica 2021 ed altri 23milioni da investimenti extra tributo.
“La disciplina dei fenomeni naturali, in epoca antica e recente, ha caratterizzato la nostra regione – ha detto Eugenio Giani, Governatore della Toscana - I Consorzi di bonifica stanno facendo un grande lavoro attraverso una capacità di disciplina del territorio, che è parte della storia locale.”
La relazione introduttiva al simposio è stata affidata al Direttore Generale ANBI, Massimo Gargano; sono poi intervenuti Luca Milani, Presidente del Consiglio Comunale di Firenze; Massimo Vincenzini, Presidente dell’Accademia Georgofili; Anna Guarducci, Docente ad Università Siena; Monia Monni, Assessore Transizione Ecologica e Sviluppo Sostenibile Regione Toscana; Cecilia Del Re, Assessore Ambiente Comune Firenze; Massimo Lucchesi, Segretario Generale Autorità Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale; Giovanni Massini, Direttore Struttura Difesa Suolo e Protezione Civile Regione Toscana.
La seconda parte della mattinata ha visto centrale il tema dei Consorzi di bonifica e dell’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura; ne hanno parlato Susanna Cenni, Vicepresidente Commissione Agricoltura Camera; Stefania Saccardi, Vicepresidente ed Assessora Agricoltura Regione Toscana; Roberto Scalacci, Direttore Agricoltura Sviluppo Rurale Regione Toscana.
“La grande sfida, che abbiamo davanti, è quella delle zone montane: abbiamo bisogno di intervenire su reticolo idraulico montano in sinergia con l’agricoltura, perché uno dei problemi all’origine è proprio l’abbandono dei terreni agricoli - ha concluso Marco Bottino, Presidente ANBI Toscana - È inoltre arrivato il momento di sviluppare nuova consapevolezza sulla necessità di recuperare piccoli-medi invasi e realizzarne di nuovi.“
LAZIO: ULTIMATI IMPORTANTI LAVORI
 I Consorzi di bonifica frusinati “Conca di Sora” (con sede a Sora) e “A Sud di Anagni” (con sede ad Anagni) hanno ultimato importanti lavori sia per la sicurezza del territorio, sia propedeutici all’irrigazione, portando a compimento un programma decennale. Con la sistemazione del torrente Rio (importante acquifero, che interessa i comuni di Montelanico, Gorga, Segni, Sgurgola e Anagni) il Consorzio di bonifica A Sud di Anagni è arrivato a completare il millesimo intervento, coprendo tutti i 750 chilometri di fossi demaniali, previsti dal vigente Piano di Classifica.
I Consorzi di bonifica frusinati “Conca di Sora” (con sede a Sora) e “A Sud di Anagni” (con sede ad Anagni) hanno ultimato importanti lavori sia per la sicurezza del territorio, sia propedeutici all’irrigazione, portando a compimento un programma decennale. Con la sistemazione del torrente Rio (importante acquifero, che interessa i comuni di Montelanico, Gorga, Segni, Sgurgola e Anagni) il Consorzio di bonifica A Sud di Anagni è arrivato a completare il millesimo intervento, coprendo tutti i 750 chilometri di fossi demaniali, previsti dal vigente Piano di Classifica.
A questo risultato va segnalato l’importante lavoro per la messa in sicurezza della strada Casilina, sponda destra del fosso Savo, nel comune di Valmontone. Il Consorzio di bonifica Conca di Sora ha portato a termine i lavori per la sistemazione della diga di Valfrancesca, a servizio dell’impianto irriguo sul fiume Liri, finanziati con il Piano Sviluppo Rurale (P.S.R.); l’ente consortile ha anche effettuato, ad Isola del Liri, lavori in convenzione con il Comune per la pulizia della cascata in centro cittadino.
VENETO: TORRENTE MESSO IN SICUREZZA
 Il Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta (con sede a San Bonifacio, in provincia di Verona) ha completato la messa in sicurezza del torrente Igna a beneficio di 4 comuni dell’Alto Vicentino: Villaverla, Sarcedo, Montecchio Precalcino e Caldogno.
Il Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta (con sede a San Bonifacio, in provincia di Verona) ha completato la messa in sicurezza del torrente Igna a beneficio di 4 comuni dell’Alto Vicentino: Villaverla, Sarcedo, Montecchio Precalcino e Caldogno.
Il valore complessivo dei lavori è di € 1.400.000,00 stanziati tramite il Fondo per la Prevenzione del Rischio Idraulico e Mitigazione dei Danni della Tempesta Vaia.
I lavori si sono articolati in 2 interventi del valore di 700.000 euro ciascuno: il primo ha interessato l’alveo nella frazione di Novoledo in comune di Villaverla, contestualmente alla realizzazione del bacino di laminazione del torrente Timonchio; il secondo sta comportando il ripristino e la messa in sicurezza degli scoli a monte della Pedemontana Veneta con particolare riferimento al ricettore principale del torrente Igna, sempre in comune di Villaverla.
LAZIO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
.jpg) Il Consorzio di bonifica Litorale Nord (con sede a Roma) ha da poco completato gli interventi di manutenzione straordinaria sul fosso Rio Galeria, finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e mirati alla riduzione del rischio esondazioni.
Il Consorzio di bonifica Litorale Nord (con sede a Roma) ha da poco completato gli interventi di manutenzione straordinaria sul fosso Rio Galeria, finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e mirati alla riduzione del rischio esondazioni.
Le criticità idrauliche, dovute allo stato di manutenzione ed ai molteplici attraversamenti viari insufficienti, sono la riprova dell’importanza strategica di questo piano, che interessa un tratto di 6.700 metri.
GARGANO A FIUMICINO E CITTA’ DELLA PIEVE
Il Direttore Generale ANBI, Massimo Gargano, interverrà nella mattinata di giovedì 16 Giugno p.v. al convegno “Dissesto idrogeologico e PNRR: quale opportunità”, organizzato dalla Cisl regionale nella sede di ANBI Lazio a Fiumicino. Sabato 18 Giugno sarà invece a Città della Pieve, in provincia di Perugia, per il convegno “Acqua e governo del territorio nella Val di Chiana Romana. Dalla Pontificia Prefettura delle Acque al Consorzio di Bonifica: passato, presente e futuro nel segno della sostenibilità”; organizzato dal Consorzio di bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia, avrà inizio alle ore 10.00 nella Sala Sant’Agostino.
Direttore Responsabile: Massimo Gargano - Registrazione Tribunale di Roma n. 559/98 del 25 novembre 1998
Redazione: Via S.Teresa, 23 - 00198 Roma - Tel. 06/844321 - Fax 06/85863616
Sito internet: anbi.it - eMail: anbimail@tin.it